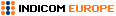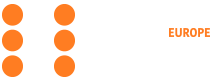L’archivistica è da sempre al centro della vita delle comunità, delle istituzioni e delle imprese. Custodire la memoria, garantire l’accesso all’informazione, rendere affidabili le fonti: compiti che, pur trasformandosi nei secoli, hanno mantenuto un ruolo cruciale.
Oggi parliamo di archivi digitali e di archivisti 4.0, ma questa è solo l’ultima tappa di un lungo percorso che parte dall’antichità e arriva fino alle piattaforme cloud globali.
Le origini: archivi come potere e memoria
Le prime testimonianze archivistiche risalgono alla Mesopotamia: tavolette d’argilla incise con transazioni commerciali, contratti e decreti. Erano custodite in vere e proprie “case degli archivi”, gestite da scribi specializzati.
Nell’antica Grecia e a Roma, i documenti ufficiali venivano conservati nei templi e nei tabularia, luoghi che garantivano la loro autenticità e la loro consultabilità. La funzione era chiara: conservare la memoria istituzionale come strumento di potere e legittimazione.
Medioevo e Rinascimento: l’archivio come ordine e sapere
Con la diffusione del pergameno, i monasteri e le cancellerie papali e regie divennero i nuovi custodi degli archivi. Si svilupparono forme di classificazione, rubriche e registri: strumenti che servivano non solo a conservare, ma anche a recuperare le informazioni in modo ordinato.
Il Rinascimento, con la nascita di grandi stati e poteri cittadini, rafforzò l’importanza di archivi pubblici e istituzionali: luoghi in cui la memoria collettiva trovava una forma organizzata e riconosciuta.
L’età moderna: la nascita dell’archivistica come disciplina
Tra XVIII e XIX secolo, con la nascita degli Stati nazionali, gli archivi assunsero una dimensione pubblica e centrale. Nacquero le istituzioni archivistiche nazionali e si codificarono metodi di classificazione e conservazione.
L’archivista divenne un professionista: custode, ma anche metodologo, capace di interpretare i documenti e di ordinarli secondo logiche razionali e scientifiche.
Il Novecento: masse documentali e primi strumenti tecnologici
Il XX secolo portò con sé un’esplosione di produzione documentale. Le aziende, le amministrazioni e le organizzazioni si trovarono a gestire quantità enormi di carte e fascicoli. Nacquero soluzioni meccaniche come i microfilm, e più tardi digitali, con i primi database e sistemi di gestione documentale.
Per la prima volta, l’archivista si trovò a dialogare con la tecnologia: non più solo carta e pergamene, ma file digitali, strumenti di riproduzione e sistemi informatici.
L’era digitale: archivi ibridi e sfide globali
Oggi viviamo in una fase di transizione continua. Gli archivi sono spesso ibridi, tra documenti cartacei storici e documenti nativi digitali. Le sfide principali riguardano:
- la conservazione digitale a lungo termine, garantendo accessibilità anche tra decenni;
- la sicurezza dei dati, nel rispetto di normative come GDPR e leggi sulla conservazione;
- la gestione dei flussi documentali globali, in aziende sempre più distribuite e multilingue;
- il cambiamento culturale, per aiutare le persone a pensare e lavorare in digitale.
Indicom: il nuovo archivista digitale
Dalle tavolette d’argilla alle nuvole digitali, l’archivistica è sempre stata una pratica di memoria, ordine e responsabilità.
Oggi, nell’era del digitale, la sfida non è più soltanto conservare, ma trasformare i dati in conoscenza affidabile, al servizio di organizzazioni e persone.
In questo scenario, Indicom interpreta l’eredità storica dell’archivistica e la porta nell’era digitale. Non solo tecnologia, ma anche metodo: classificazione, tracciabilità, governance e sicurezza.
Indicom si pone come anello di congiunzione in questa lunga storia: dall’antico archivista custode al moderno archivista digitale, sempre con lo stesso obiettivo — dare valore alla memoria e renderla accessibile nel tempo.